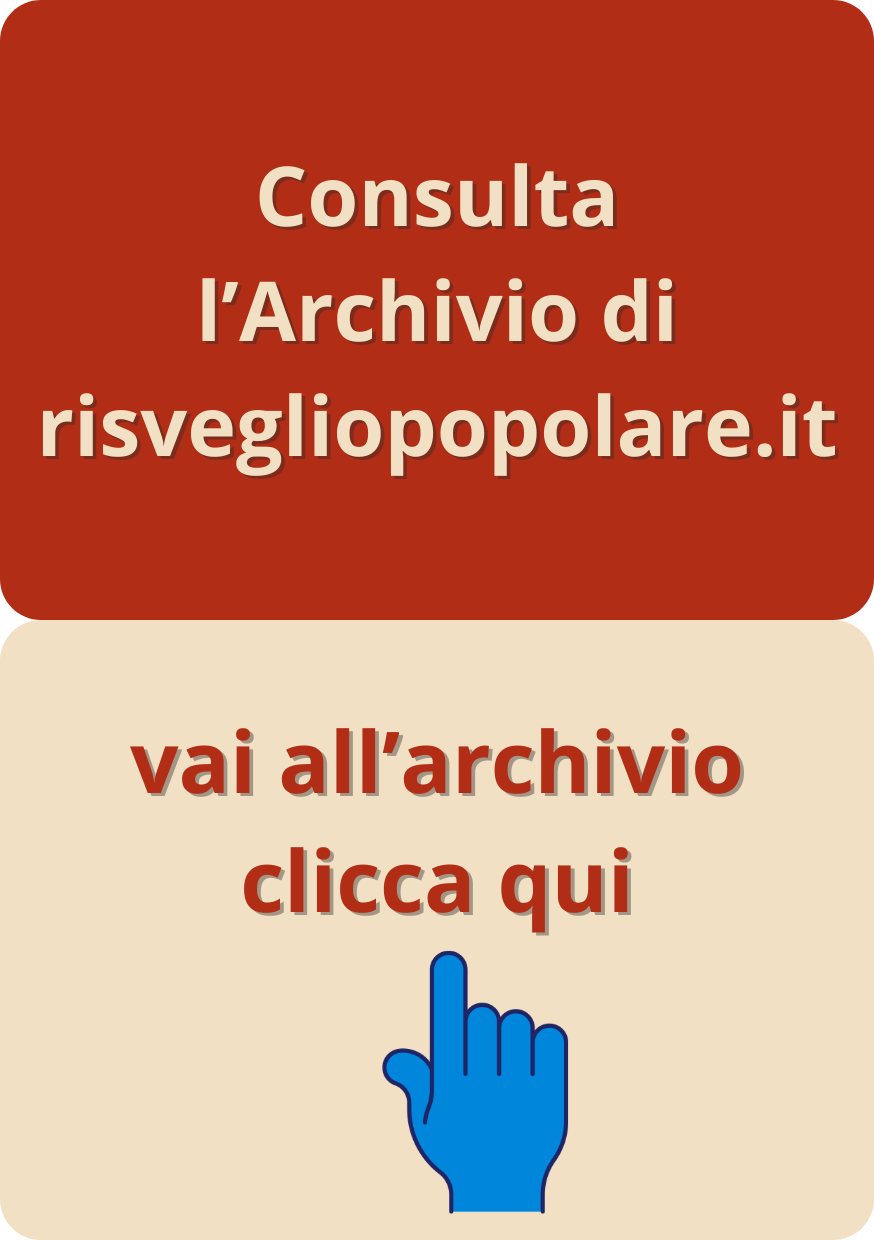Commento ai Vangeli dei giorni di Natale
(Elisa Moro)
“Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere” (Lc. 2,15). È il mistero dell’Incarnazione, del Santo Natale, che si svela davanti agli occhi adoranti e meravigliati, mentre le ginocchia si piegano davanti al silenzioso Bambino di Betlemme: Dio, si fa carne, scegliendo di avere bisogno di tutto, a cominciare dalla protezione di una Madre. Il Signore della gloria si ammanta di povertà, la Luce vera vince le tenebre del peccato, la Parola creatrice si riveste di umanità.
25 dicembre, Solennità del Natale
Andiamo incontro al Re che giace nella paglia: l’Incarnazione ha luogo nella notte, quella dei fallimenti umani, delle debolezze e fatiche, della infeconda paura che il sole non possa più sorgere. Anche gli ebrei attraversarono le acque del Mar Rosso nell’oscurità, venendo alla luce, oltrepassando la schiavitù egiziana, uscendo fuori da una dimensione di oppressione per assaporare la libertà di Dio. Similmente nella greppia di Betlemme, i pastori muovono i loro passi nel buio per essere avvolti dalla Luce vera, che rende capaci di illuminare, di testimoniare, poiché si imprime negli occhi e nel cuore degli uomini di ogni epoca. Si diventa “luce per illuminare le genti”; con le parole pronunciate dal vecchio Simeone, dove si coglie la pienezza donata dall’incontro con Cristo: il desiderio di rinnovarsi per essere uno con lui. L’andare a Betlemme non è quindi un viaggio di sola andata, ma un testimoniare, “attraverso cammini di fede concreti e nel servizio al prossimo – disse Benedetto XVI nell’omelia della vigilia del 2014 – in cui Cristo mi attende”…
26 dicembre, Festa di Santo Stefano
È questa la testimonianza di Santo Stefano: protomartire, tra i vicini a Cristo, perseverante nel tenere lo sguardo “fisso al cielo” (At. 7, 55), che conduce ad una conversione continua e autentica a immagine Sua. Essere segno, fino a donarsi, sull’esempio di Santo Stefano: è il secondo elemento distintivo del tempo natalizio, ma anche dell’intera vita del cristiano. Come segno viene offerta l’abituale fasciatura, tipica per tutti i neonati, che però racchiude in sé un messaggio più profondo: la gloria del Signore, che compete al Figlio di Dio, si nasconde nella povertà delle fasce; lì, e non altrove, occorre cercarla e riconoscerla, trovarla in una storia vera, tangibile, concreta.
Quelle fasce sono la prima prova d’amore del Verbo fatto carne, sono segno di quell’abito da servo che ha assunto per salvare l’umanità ferita. La tradizione della Chiesa ha posto in risalto il parallelismo tra la fasciatura di Maria e quella di Giuseppe di Arimatea, ponendo una simmetria tra la ‘mangiatoia’ e il ‘sepolcro’; questo sembra urtare quella concezione sentimentalistica del Natale, così poco cristiana seppur diffusa, ma l’ombra della Croce, che sempre si cela dietro alla culla natalizia, mette in risalto la pienezza del mistero di quel Bimbo, fattosi uomo per redimere la carne mortale. È proprio nella pienezza della Risurrezione che il ‘segno degli angeli’ trova il pieno significato: la tomba vuota, nella quale giacciono soltanto le bende; Gesù, risorgendo, non ha deposto la nostra umanità; di essa ha abbandonato le fasce in cui era avvolto fin dalla nascita. Egli stesso è il Segno, nella Sua vita, Passione, Morte e Risurrezione, segno di “contraddizione” che svela i pensieri di molti cuori, i desideri più profondi dell’uomo. Il Signore chiede di “diventare segno”, di essere “risposta a una Parola che interpella personalmente, a un Tu che chiama per nome” (Lumen Fidei, 8), portatori di Fede nel mondo, testimoni dell’avvenimento vissuto nell’esistenza. Questo è quanto insegna Stefano e i martiri, in cui il dono di sé stessi rivela di avere incontrato il Tutto, la pienezza della vita.
27 dicembre, Festa della Santa Famiglia
“Una luce dal cielo, più splendente del sole” (At. 26, 13): nel mistero della Santa Famiglia risplende la Gloria di Dio. La gloria di Dio si manifesta nella pienezza dei tempi, nella notte di Natale, attraverso gli angeli, messaggeri del lieto annuncio. L’evangelista Luca contrappone i pastori, avvolti della gloria di Dio al Bambino Gesù, avvolto in fasce, bende umili che non riflettono luce, ma la sua condizione di Figlio dell’uomo. La gloria, la splendida luce che abbaglia e che sempre definisce la manifestazione vittoriosa del Risorto, circonda gli ultimi, i più deboli, a indicare la nuova creazione, il nuovo abito di cui sono rivestiti.
La luce che in principio ha creato ogni cosa ora nel suo fulgore è visibile nel Figlio, nascosto sotto la carne per permettere all’uomo di essere vista, nella concretezza di una famiglia umana. Ecco allora i “cieli aperti” (At. 7, 55) contemplati da Stefano, ecco gli occhi, logorati dall’età, di Simeone, che “han visto la tua salvezza”, ecco lo stupore dei pastori inondati di luce, ecco, infine, la meraviglia e la gioia del cristiano: la luce accompagna la quotidianità e invita ad adorare il Verbo incarnato nelle situazioni concrete di ogni giorno, ad essere famiglia, sull’esempio di quella di Nazareth, grembo capace di accogliere e di donare.
elisa moro